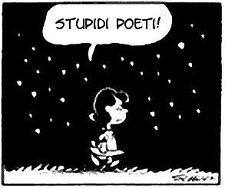Da «Quello che resta da fare ai poeti» (1911)
Ai poeti resta da fare la poesia onesta.
C’è un contrapposto, che se può sembrare artificioso, pure rende abbastanza bene il mio pensiero. Il contrapposto è fra i due uomini nostri più compiutamente noti che meglio si prestano a dare un esempio di quello che intendo per onestà e disonestà letteraria: è fra Alessandro Manzoni e Gabriele D’Annunzio: fra gli Inni sacri e i Cori dell’Adelchi, e il secondo libro delle Laudi e la Nave: fra versi mediocri ed immortali e magnifici versi per la più parte caduchi. L’onestà dell’uno e la nessuna onestà dell’altro, così verso loro stessi come verso il lettore (perché chi à un candido rispetto per l’anima propria, lo à anche, all’infuori della stima o disistima, per quella a cui si rivolge) sono i due termini cui può benissimo ridursi la differenza tra i due valori.
A chi sa andare ogni poco oltre la superficie dei versi, apparisce in quelli di Manzoni la costante e rara cura di non dire una parola che non corrisponda perfettamente alla sua visione: mentre vede che l’artificio del D’Annunzio non è solo formale ma anche sostanziale, egli si esagera o addirittura si finge passioni e ammirazioni che non sono mai state nel suo temperamento: e questo imperdonabile peccato contro lo spirito egli lo commette al solo e ben meschino scopo di ottenere una strofa più appariscente, un verso più clamoroso. Egli si ubriaca per aumentarsi, l’altro è il più astemio e il più sobrio dei poeti italiani: per non travisare il proprio io e non ingannare con false apparenze quello del lettore, resta se mai al di qua dell’ispirazione. Questa austerità, in lui innata, era poi accresciuta da motivi religiosi: perché certo egli credeva che Dio che gli aveva dato il genio, gli avrebbe chiesto conto di ogni parola, direi quasi di ogni interpretazione. Ne viene che quando ad uno dei due manca con la perfetta espressione la perfetta opera d’arte, se questi è il Manzoni, non per tanto egli ci diventa antipatico, come uno che erra per imperizia o per paura di derogare da quello che in buona fede ritiene che sia il giusto ed il vero; se invece è il d’Annunzio egli ci irrita e disgusta come un individuo che spenda la sua ammirevole eloquenza meridionale per imporci una mercanzia sospetta. E se gli imitatori o i minori danno un’idea ancora più precisa di una tendenza, come quelli che o la esagerano o non la superano universalizzandosi, si vede che mentre la lirica di Manzoni, anche immiserita in quella dei seguaci, dà pur sempre qua e là alcune strofe degne di essere apprese con rispetto, le Laudi si gonfiano ed esplodono nei manifesti stradali del Futurismo. Da un manzoniano, anche di non altissimo ingegno, si poteva sempre attendersi qualcosa di buono, perché aveva appreso dal maestro non la necessità di essere un grand’uomo né uno scrittore originale ad ogni costo: ma quella di essere, nella vita come nella letteratura, un uomo onesto.
Chi non fa versi per il sincero bisogno di aiutare col ritmo l’espressione della sua passione, ma à intenzioni bottegaie o ambiziose, e pubblicare un libro è per lui come urgere una decorazione o aprire un negozio, non può nemmeno immaginare quale tenace sforzo dell’intelletto e quale disinteressata grandezza d’animo occorra per resistere ad ogni lenocinio, e mantenersi puri e onesti di fronte a se stessi: anche quando il verso menzognero è, preso singolarmente, il migliore. E come la nobiltà dell’atteggiamento così ignora l’estrema rarità del successo, o è capace d’illudersi d’averla pienamente raggiunta, senza nemmeno sapere in che consista, perché non c’è per credere di saper tutto che chi non sa niente. Ma quei pochi che m’intendono e riconoscono nel mio travaglio il loro travaglio, e nella mia speranza la loro speranza, quelli riconosceranno con me che ben pochi passi sono stati ancora fatti in questa che è la via eterna dell’arte, e in questo momento anche la più ardita e la più nuova. Nuova! ecco la parola che se fa trasalire gli artisti fa tremare i poeti, perché in nessun’arte le inconsce reminiscenze sono più frequenti che in poesia, dove vengono favorite dalla natura stessa e dall’inevitabile virtù del suono, che le imprime indelebilmente nella memoria. Di una poesia non resta solo, come di una prosa, lo spirito che l’animava, ma anche la materia in cui s’è incarnato; non è la commemorazione dei protestanti, ma l’ostia del rito cattolico; tutto il corpo e tutta l’anima del Signore. Quando parlando di un romanzo, di una novella, di un’opera d’arte o di pensiero, si riportano solo i fatti o i sentimenti o le idee che vi sono espressi, di un poeta si ripetono addirittura i versi. E quanto più son facili le volontarie imitazioni tanto più necessaria diventa la loro medicina, che è quello che ò chiamato onestà letteraria: che è prima un non sforzare mai l’ispirazione, poi non tentare per meschini motivi di ambizione o di successo, di farla parere più vasta e trascendente di quanto per avventura essa sia: è reazione, durante il lavoro, alla pigrizia intellettuale che impedisce allo scandaglio di toccare il fondo; reazione alla dolcezza di lasciarsi prender la mano dal ritmo, dalla rima, da quello che volgarmente si chiama la vena. Benché esser originali e ritrovar se stessi siano termini equivalenti, chi non riconosce in pratica che il primo è l’effetto e il secondo la causa; e parte non dal bisogno di riconoscersi ma da uno sfrenato desiderio di originalità, per cui non sa rassegnarsi, quando occorre, a dire anche quelli che gli altri ànno detto; non ritroverà mai la sua vera natura, non dirà mai alcunché di inaspettato. Bisogna – non mi si prenda alla lettera – essere originali nostro malgrado. Ed infatti quali artisti lo sono meno che quelli in cui è visibile lo sforzo per diventarlo? Essi non riescono il più delle volte a essere nemmeno originali: e vanno tanto più famosi per la spudoratezza dei furti e la vastità dei saccheggi: in quanto che nello stesso tempo che compiono una rapina la condannano, e si affermano miliardari che vivono del proprio. Anche mi apparisce dannosa la paura di ripeter se stessi: quando un sentimento è innato ed è innato il bisogno dell’espressione, è naturale che fino che l’uomo non può uscire dal proprio io, quel sentimento e quell’espressione si ripetano, con l’ossessione di chi sente qualcosa che la parola e il suono e tutte le arti e tutti i mezzi esteriori non possono mai rendere alla perfezione: quindi l’inappagamento dopo ogni opera e la speranza di dir meglio la prossima volta. Sono pieni di ripetizioni il Canzoniere del Petrarca e quello del Leopardi, e la parte più sublime della Commedia «Il Paradiso»: poiché questi poeti cercano di sfogare una loro grande passione e non di sbalordire come dei giocolieri; che guai se ripetono due volte lo stesso numero. E se l’ispirazione è sincera e subisce quindi l’influenza del particolar momento in cui nasce, c’è sempre, per quante volte si ripeta, qualcosa che la contraddistingue: una inaspettata freschezza o una più grande stanchezza, uno scorcio di spettatore e di paesaggio, una diversa stagione od ora del giorno; qualcosa che dà al verso il suo colore unico e che solo l’occhio del profano può confondere con l’impressione antecedente. Né questa onestà è possibile che in chi à la religione dell’arte, e l’ama per se stessa e non per la speranza della gloria, ma il paradiso del successo o il purgatorio dell’insuccesso, se non lo lasciano del tutto indifferente, non menomano il suo amore e non lo fanno, per avidità di battimani, volgere né a destra, né a sinistra.
Così egli si guarda bene dallo sforzare l’ispirazione, anzi, per il dubbio d’ingannarsi, resiste ad essa, e non le cede che quando à acquistato la violenza dell’istinto. Ma proprio allora e più che mai difficile e necessario questo studio di non oltrepassarsi, di non verseggiare sopra una falsariga d’altri; è nei momenti più impetuosi che si corre il rischio di perdere la propria strada, come un cavallo lanciato ad un galoppo troppo sfrenato. È pertanto che bisogna con lunga disciplina prepararsi a ricevere la grazia con animo proprio; fare un quotidiano esame di coscienza, rileggersi in quei periodi di ristagno in cui è più possibile l’analisi, cercando sempre di ricordarsi lo stato d’animo che à generato quei versi e rilevando con eroica meticolosità la differenza fra il pensato e lo scritto. Vorrei si facesse per l’arte quello che i modernisti ànno fatto per la religione, senza paura di distruggere quello che amavano dall’infanzia: cade una chiesa ed un’altra ne sorge: se dopo la vivisezione alcuno si accorgesse che ben pochi dei suoi sentimenti richiedono la poesia, che faccia solo quel poco o magari niente, e ricerchi in un laborioso ozio quello che può sostituire per lui la poesia in versi. È solo con questo metodo che potrà una buona volta esser messo in chiaro quanto è rimasto di vivo della più antica forma di espressione letteraria, contro la quale oggi ci son tante e in parte così giustificate prevenzioni: solo quando i poeti, o meglio il maggior poeta di una generazione, avrà rinunciato alla degradante ambizione propria — purtroppo! — ai temperamenti lirici, e lavorerà con la scrupolosa onesta dei ricercatori del vero, si vedrà quello che non per forza d’inerzia, ma per necessità deve ancora essere significato in versi.
[…]
A questa maggiore onestà nel metodo di lavoro, deve necessariamente corrispondere un più austero programma di vita. II poeta deve tendere ad un tipo morale il più remoto possibile da quello del letterato di professione, ed avvicinarsi invece a quello dei ricercatori di verità esteriori o interiori, le quali, salvo forse la più alta forma d’intellettualità che occorre per investigare le seconde, sono tutt’una cosa. — Alcuni poeti della vecchia generazione furono come dei contemplativi, che per nausea dell’antica aspirazione, o per impotenza a raggiungere per quella via l’estasi, vollero diventare una specie d’uomini d’azione. Allora scambiarono l’abito claustrale per l’uniforme soldatesca, e partirono per una guerra dove il loro eroismo diventò vigliaccheria mascherata di temerarietà: dove il loro gesto di comando, tanto più elegante quanto più sbagliato, suscitava il turpiloquio o la giusta indignazione dei commilitoni, così pieni nei loro combattimenti, di un facile buon senso e di un abbominevole senso pratico. Essi disprezzarono la loro alta femminilità per esaltare la virilità abbietta dei conquistatori di mercati e d’imperi. Cercarono i loro modelli e le loro similitudini fra gli eroi dell’armi, quando avrebbero dovuto cercarli fra quelli ben più nobili del pensiero e del sentimento. Al di là del mondo del poeta non c’è che quello dei santi e forse quello dei filosofi; essi, per uscire dalla vecchia cerchia, entrarono in un girone inferiore, fra anime più volgari e aspirazioni più meschine. Ivi essi apparirono al confronto ancor più meschini: e non riuscirono che a sciupare le energie personali e il patrimonio della tradizione.
Ai poeti della generazione presente resta da fare quello che dovrebbero fare i figlioli, i cui genitori furono mala-mente prodighi di averi e di salute: una vita di riparazione e di penitenza, senza la preoccupazione di essere essi o i posteri a cogliere il frutto dell’attività riparatrice. Essi si possono anche confrontare a dei malati, lontani dalla loro patria, la cui ultima speranza di guarigione è l’aria nativa. Così resta ad essi, per condurre un’esistenza utile e generare figli sani, un ritorno alle origini: con un’opera forse più di selezione e di rifacimento che di novissima creazione: resta ad essi quello che finora fu solo raramente e parzialmente compiuto, la poesia onesta.
Trieste, Febbraio 1911