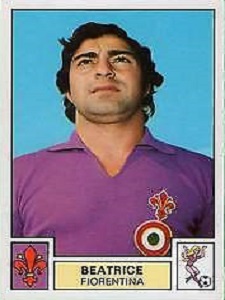[Da «Nove saggi danteschi»]
È mia intenzione commentare i versi più patetici che la letteratura ci abbia dato. Li include il Canto XXXI del Paradiso, e benché siano famosi, nessuno pare aver compreso il dolore che vi è in essi, nessuno li ha ascoltati interamente. È ben vero che la tragica sostanza che racchiudono appartiene meno all’opera che all’autore dell’opera, meno a Dante protagonista che a Dante redattore o inventore.
Ecco la situazione. Sulla vetta del monte del Purgatorio, Dante perde Virgilio. Guidato da Beatrice, la cui bellezza si accresce a ogni nuovo cielo che toccano, percorre sfera dopo sfera concentrica, fino a salire a quella che circonda le altre, quella del Primo Mobile.
Ai suoi piedi stanno le stelle fisse; sopra di esse l’Empireo, che non è più cielo corporale ma eterno, fatto solo di luce.
Ascendono all’Empireo; in quella infinita regione (come nelle tele preraffaellite) il remoto non è meno nitido di ciò che sta molto vicino.
Dante vede un alto fiume di luce, vede schiere di angeli, vede la molteplice Rosa paradisiaca che formano, disposte ad anfiteatro, le anime dei Giusti. Improvvisamente avverte che Beatrice lo ha lasciato. La vede lassù, in uno dei cerchi della Rosa. Come un uomo che in fondo al mare alza gli occhi alla regione del tuono, così la venera e la implora. Le rende grazie per la sua benefica pietà e le raccomanda la propria anima. Il testo dice allora:
Così orai; e quella sì lontana
come parea, sorrise e riguardommi;
poi si tornò all’etterna fontana.
(Dante, Paradiso, 31: 91-93)
Come interpretare quanto precede? Gli allegoristi ci dicono: la ragione (Virgilio) è uno strumento per raggiungere la fede; la fede (Beatrice), uno strumento per raggiungere la divinità; entrambe si perdono, una volta raggiunto lo scopo. La spiegazione, come avrà avvertito il lettore, non è meno impeccabile che frigida; da un misero schema come questo, non sono mai usciti quei versi.
I commenti che ho interrogato non vedono nel sorriso di Beatrice che un simbolo di acquiescenza.
«Ultimo sguardo, ultimo sorriso, ma promessa certa» annota Francesco Torraca. «Sorride per dire a Dante che la sua preghiera è stata accettata; lo guarda per significargli ancora una volta l’amore che gli porta» conferma Luigi Pietrobono. Questo parere (che è anche quello di Casini) mi sembra molto giusto, ma è evidente che sfiora appena la scena. Ozanam (Dante et la philosophie catholique, 1895) pensa che l’apoteosi di Beatrice fu il tema primitivo della Commedia; Guido Vitali si chiede se Dante, creando il Paradiso, non sia stato mosso anzitutto dal proposito di fondare un regno per la sua dama.
Un famoso passo della Vita Nuova («Io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d’alcuna») giustifica o permette questa congettura.
Io andrei più lontano. Io sospetto che Dante edificò il miglior libro che la letteratura abbia mai prodotto per interpolarvi alcuni incontri con l’irrecuperabile Beatrice.
Per dir meglio: i cerchi del castigo e il Purgatorio australe e i nove cerchi concentrici e Francesca e la sirena e il Grifone e Bertrand de Born sono interpolazioni; un sorriso e una voce, che egli sa perduti, sono la cosa fondamentale. All’inizio della Vita Nuova si legge che Dante una volta enumerò in un’epistola sessanta nomi di donne per far scivolare tra essi, segreto, il nome di Beatrice. Penso che nella Commedia ripeté questo malinconico gioco.
Che uno sfortunato si immagini la felicità non ha nulla di singolare; tutti noi, ogni giorno, lo facciamo. Dante lo fa come noi, ma qualcosa, sempre, ci lascia intravedere l’orrore che nascondono queste felici finzioni.
In una poesia di Chesterton si parla di nightmares of delight, di incubi di piacere; questo ossimoro più o meno definisce la citata terzina del Paradiso. Ma l’enfasi, nella frase di Chesterton, cade sulla parola delight; nella terzina, sul nightmare.
Riconsideriamo la scena. Dante, con Beatrice accanto, si trova nell’Empireo. Sopra di loro si dispiega, incommensurabile, la Rosa dei Giusti. La Rosa è lontana, ma le forme che la popolano sono nitide. Questa contraddizione, anche se giustificata dal poeta (Paradiso, 30: 118), costituisce forse il primo indizio di un’intima discordia.
Beatrice, improvvisamente, non è più accanto a lui. Un vecchio ha preso il suo posto («credea veder Beatrice, e vidi un sene»).
Dante riesce appena a chiedere dov’è Beatrice. «Ov’è ella?» grida.
L’anziano gli mostra uno dei cerchi dell’altissima Rosa. Lì, aureolata, c’è Beatrice; Beatrice il cui sguardo soleva colmarlo di intollerabile beatitudine, Beatrice che soleva vestirsi di rosso, Beatrice a cui aveva pensato tanto che lo sgomentò considerare che alcuni pellegrini, da lui visti una mattina a Firenze, non avevano mai sentito parlare di lei, Beatrice che una volta gli negò il saluto, Beatrice che morì a ventiquattro anni, Beatrice di Folco Portinari, che si sposò con Bardi.
Dante la scorge lassù; il chiaro firmamento non è più lontano dal più profondo del mare che lei da lui. Dante la prega come pregasse Dio, ma anche come una donna desiderata:
O donna in cui la mia speranza vige,
e che soffristi per la mia salute
in inferno lasciar le tue vestige …
(Dante, Paradiso, 31: 79-81)
Beatrice allora lo guarda un istante e sorride, per poi volgersi all’eterna fonte di luce.
Francesco de Sanctis (Storia della letteratura italiana, VII) intende così il passo: «Quando Beatrice si allontana, Dante non manda un lamento: ogni parte terrestre è in lui arsa e consumata». Questo è vero, se consideriamo il proposito del poeta; erroneo, se consideriamo il sentimento.
Soffermiamoci su un fatto incontrovertibile, un solo fatto umilissimo: la scena è stata immaginata da Dante. Per noi è molto reale; per lui lo fu meno. (La realtà, per lui, era che prima la vita e poi la morte gli avevano strappato Beatrice).
Assente per sempre da Beatrice, solo e forse umiliato, immaginò la scena per immaginare che stava con lei. Sfortunatamente per lui, felicemente per i secoli che l’avrebbero letto, la coscienza che quell’incontro era immaginario deformò la visione.
Da qui le circostanze atroci, tanto più infernali, chiaro, in quanto avvengono nell’Empireo: la scomparsa di Beatrice, il vecchio che ne prende il posto, la sua brusca elevazione alla Rosa, la fugacità del sorriso e dello sguardo, il volgersi eterno del volto.
Nelle parole traspare l’orrore: come parea si riferisce a lontana ma contamina sorrise, e così Longfellow poté tradurre nella sua versione del 1867:
Thus I implored; and she, so far away,
smiled as it seemed, and looked once more at
me …
Anche etterna sembra contaminare si tornò.